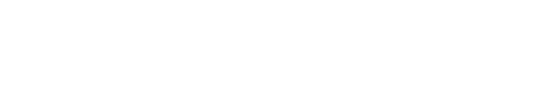Indice degli argomenti
La guida sotto l’effetto di droghe è uno dei temi più controversi nel panorama normativo italiano, soprattutto alla luce delle recenti modifiche introdotte dal nuovo codice della strada. Questo argomento non si limita a sollevare questioni di sicurezza stradale, ma tocca aspetti fondamentali come la giustizia, la proporzionalità delle pene e il rispetto dei diritti costituzionali.
Il quadro normativo attuale sulla guida sotto l’effetto di droghe
Secondo l’articolo 187 del Codice della Strada, la guida sotto l’effetto di droghe derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti costituisce un reato penale. La norma, prima delle modifiche introdotte dalla riforma Salvini, prevedeva due condizioni necessarie per configurare l’illecito di guida sotto l’effetto di droghe:
- La positività al test per sostanze stupefacenti.
- La dimostrazione dello stato di alterazione psicofisica del conducente, verificato attraverso accertamenti clinici.
Questa impostazione bilanciava la necessità di garantire la sicurezza stradale con il principio della proporzionalità della pena: il reato di guida sotto l’effetto di droghe era configurato solo se il conducente si trovava in uno stato di effettivo pericolo per sé e per gli altri.
Cosa cambia con la riforma Salvini
La riforma ha eliminato il requisito dello stato di alterazione psicofisica, rendendo sufficiente per la guida sotto l’effetto di droghe un test positivo alle droghe per configurare il reato. Questo significa che chiunque venga sottoposto a un controllo e risulti positivo a una sostanza stupefacente, indipendentemente dal momento in cui l’ha assunta e dalla sua condizione al momento della guida, può essere sanzionato penalmente.
La riforma si basa sull’idea che la presenza di sostanze nel corpo, anche se assunte giorni o settimane prima, sia di per sé sufficiente a giustificare una punizione. Tuttavia, questa modifica normativa ha generato un acceso dibattito, mettendo in luce numerose criticità in merito alla guida sotto l’effetto di droghe.
Le problematiche principali
1. Penalizzazione di condotte non pericolose
La principale critica alla nuova normativa riguarda il fatto che si puniscono anche condotte che non rappresentano un pericolo reale per la circolazione stradale. Ad esempio:
- Una persona che ha assunto droga 15 giorni prima, e che non è più sotto l’effetto della sostanza, può risultare positiva al test effettuato con il prelievo del sangue o del capello.
- In casi simili, il conducente potrebbe essere considerato penalmente responsabile e subire sanzioni come la sospensione della patente, anche se la sua guida non risulta compromessa.
Questo approccio contrasta con il principio costituzionale di colpevolezza (articolo 27 della Costituzione italiana), secondo cui una persona può essere punita solo per condotte effettivamente pericolose o dannose.
2. Test invasivi e discrezionalità nell’applicazione
Un’altra criticità riguarda i test utilizzati per accertare la presenza di droghe:
- Test salivari: Rilevano la presenza di sostanze assunte nelle ultime 8-10 ore. Sono meno invasivi, ma la loro affidabilità può essere messa in discussione.
- Test del sangue e del capello: Rilevano la presenza di sostanze anche settimane dopo l’assunzione, pur non essendo indicativi di uno stato di alterazione al momento della guida.
In molti casi, la polizia ricorre a test più invasivi anche in assenza di un’effettiva necessità. La normativa, infatti, permette agli agenti di ordinare accertamenti clinici basandosi su un “ragionevole motivo”. Tuttavia, questa discrezionalità può portare ad abusi o interpretazioni arbitrarie. Ad esempio, la semplice presenza di amici che appaiono “sballati” in macchina potrebbe essere sufficiente a giustificare un test.
3. Contraddizioni rispetto ad altri contesti normativi
Un ulteriore punto di discussione riguarda il trattamento normativo della droga rispetto all’alcol:
- Nel caso dell’alcol, i test si concentrano esclusivamente sul livello di alterazione al momento della guida. Ad esempio, un bicchiere di vino bevuto due settimane prima non comporta alcuna conseguenza.
- Nel caso delle droghe, invece, si punisce anche una condotta che non produce effetti attuali sulla capacità di guida, come l’assunzione di sostanze molto tempo prima.
Questa disparità di trattamento solleva dubbi sulla coerenza delle scelte legislative e sull’effettiva volontà di tutelare la sicurezza stradale, piuttosto che perseguire un obiettivo moralizzatore contro l’uso delle droghe.
Il rischio di incostituzionalità
La nuova normativa potrebbe violare diversi principi costituzionali:
- Principio di proporzionalità: La punizione dovrebbe essere commisurata alla gravità della condotta e al pericolo effettivamente causato. Punire chi non è in stato di alterazione psicofisica sembra eccedere questo principio.
- Principio di colpevolezza: La colpevolezza richiede una condotta consapevole e pericolosa. Penalizzare la semplice positività a un test senza considerare l’effettiva pericolosità della guida potrebbe essere incostituzionale.
- Principio della funzione rieducativa della pena: Punire condotte che non rappresentano un rischio reale rischia di compromettere l’obiettivo rieducativo della sanzione.
Le conseguenze pratiche della riforma
L’applicazione della nuova normativa sta già avendo effetti significativi:
- Aumento delle contestazioni: Un numero crescente di persone si ritrova a dover affrontare sanzioni, ricorsi e sospensioni della patente, anche per condotte non pericolose.
- Sovraccarico del sistema giudiziario: L’aumento delle contestazioni rischia di intasare i tribunali, rallentando ulteriormente i procedimenti legali.
- Critiche sociali e politiche: La riforma è percepita da molti come uno strumento punitivo, più che come una reale misura di sicurezza stradale.
Proposte per un approccio più equilibrato
Per affrontare le criticità della normativa, sarebbe opportuno introdurre alcune modifiche:
- Ripristino del requisito dello stato di alterazione psicofisica: La punibilità dovrebbe essere legata alla pericolosità effettiva del conducente al momento della guida.
- Maggiore chiarezza sui “ragionevoli motivi”: Andrebbero definite con precisione le circostanze che giustificano test invasivi, per ridurre il rischio di abusi.
- Uniformità di trattamento tra droghe e alcol: Le norme dovrebbero garantire un approccio coerente e basato su criteri scientifici.