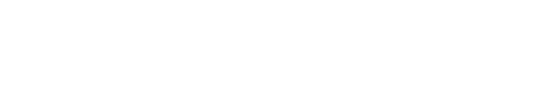Indice degli argomenti
La guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti rappresenta uno dei temi centrali della riforma del Codice della Strada 2024. Attraverso un sistema di controllo e sanzioni più rigido, il legislatore mira a ridurre l’incidentalità stradale e a garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada. Tuttavia, questa normativa presenta diverse criticità, sia sul piano giuridico che operativo, sollevando questioni di proporzionalità e giustizia.
Nuove disposizioni per il controllo della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Il Codice della Strada 2024 introduce un protocollo articolato in tre fasi per verificare l’assunzione di sostanze stupefacenti. Questo approccio progressivo è stato pensato per aumentare l’efficacia dei controlli, ma presenta limiti significativi nella pratica:
- Test preliminari con precursori portatili: questi dispositivi, che permettono un controllo rapido e non invasivo, dovrebbero rappresentare il primo livello di screening. Tuttavia, la circolare ministeriale ha evidenziato una carenza nella disponibilità di tali strumenti, costringendo spesso le Forze dell’Ordine a saltare questa fase.
- Test salivari avanzati: in alternativa ai precursori, gli agenti possono utilizzare test salivari per rilevare sostanze assunte nelle ore precedenti. Sebbene siano strumenti più accurati, non distinguono sempre tra consumo recente e residui metabolici privi di effetto, generando incertezze sull’applicazione delle sanzioni.
- Accertamenti biologici in laboratorio: quando i test preliminari risultano positivi, il conducente viene sottoposto a esami più approfonditi, come analisi di sangue, urine o capelli. Sebbene altamente precisi, questi test possono rilevare tracce di sostanze consumate settimane o mesi prima, senza che ciò comporti un’effettiva alterazione psicofisica al momento della guida.
Questa procedura evidenzia un conflitto tra la necessità di accuratezza e la praticità operativa, con il rischio di disparità nell’applicazione delle norme.
Assenza di una soglia di tolleranza per le sostanze stupefacenti
A differenza della guida in stato di ebbrezza, per cui è prevista una soglia di tolleranza di 0,5 g/l, la normativa relativa alle sostanze stupefacenti non stabilisce limiti minimi. Anche una minima traccia rilevata durante i controlli può portare a severe sanzioni, indipendentemente dall’effettiva alterazione delle capacità di guida.
- Implicazioni scientifiche: secondo esperti come il direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacologia Clinica della Statale di Milano, alcune sostanze, come i cannabinoidi, si dissipano nel sangue entro 24 ore senza influire sulla capacità di guida. Tuttavia, i test attuali rilevano residui metabolici non attivi, creando un margine di incertezza.
- Critiche normative: l’assenza di una soglia minima di tolleranza solleva dubbi sulla proporzionalità delle sanzioni, rischiando di penalizzare anche conducenti che non rappresentano un pericolo reale per la sicurezza stradale.
L’impatto sui pazienti che utilizzano cannabinoidi a scopo terapeutico
Una questione particolarmente delicata riguarda i pazienti che assumono cannabinoidi per trattamenti medici. Sebbene l’uso terapeutico sia riconosciuto e legale, l’attuale normativa non distingue tra consumo medico e ricreativo, esponendo i pazienti a sanzioni ingiustificate.
- Discriminazione normativa: l’assenza di una regolamentazione specifica ignora il contesto dell’assunzione terapeutica, penalizzando ingiustamente i pazienti.
- Richieste di riforma: associazioni di pazienti e professionisti sanitari chiedono esenzioni specifiche per chi utilizza cannabinoidi sotto prescrizione medica, garantendo un trattamento più equo e rispettoso delle esigenze cliniche.
Criticità operative e giuridiche
La riforma del Codice della Strada ha messo in evidenza diverse problematiche che influiscono sull’efficacia e sull’equità delle disposizioni:
Mancanza di strumenti adeguati
La scarsa disponibilità di precursori portatili limita la possibilità di effettuare controlli preliminari rapidi e non invasivi. Questa lacuna operativa non solo rallenta i controlli, ma aumenta anche i costi e le difficoltà per le Forze dell’Ordine.
Sproporzione degli accertamenti biologici
Gli esami di laboratorio, pur essendo strumenti di alta precisione, risultano sproporzionati nel contesto della sicurezza stradale. Non distinguendo tra consumo attuale e tracce metaboliche prive di effetti alteranti, rischiano di portare a sanzioni eccessive.
Disparità con la normativa sull’alcol
Mentre per l’alcol è prevista una soglia di tolleranza che consente un margine di consumo legale, per le droghe qualsiasi quantità rilevata è sufficiente per l’incriminazione. Questa differenza crea un trattamento ineguale tra situazioni potenzialmente analoghe, generando disparità normative. Sul punto, leggi l’approfondimento relativo alle multe per guida in stato d’ebbrezza.
Proposte per migliorare la normativa
Per affrontare le criticità emerse e garantire maggiore equità nella regolamentazione della guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, si potrebbero adottare le seguenti misure:
- Introduzione di una soglia minima di tolleranza: definire un limite che consenta di distinguere tra residui metabolici innocui e alterazione effettiva delle capacità psicofisiche.
- Dotazione di strumenti adeguati alle Forze dell’Ordine: garantire la disponibilità di precursori portatili su tutto il territorio nazionale per migliorare la rapidità e l’efficacia dei controlli.
- Tutela per l’uso terapeutico: introdurre esenzioni specifiche per chi utilizza cannabinoidi a scopo medico, evitando sanzioni ingiuste.
- Rafforzamento della sensibilizzazione e prevenzione: promuovere campagne informative per educare i cittadini sui rischi della guida sotto l’effetto di sostanze.
- Revisione della normativa: aggiornare le disposizioni sulla base di criteri scientifici condivisi, garantendo proporzionalità e adeguatezza delle sanzioni.
La riforma del Codice della Strada 2024 ha introdotto misure significative per contrastare la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ma evidenzia diverse criticità in termini di applicazione e proporzionalità. L’assenza di una soglia di tolleranza, la rigidità delle sanzioni e la mancanza di strumenti adeguati rischiano di compromettere l’obiettivo primario di garantire la sicurezza stradale. Una revisione normativa che bilanci esigenze di sicurezza e diritti individuali appare indispensabile per rendere il sistema più equo ed efficace.